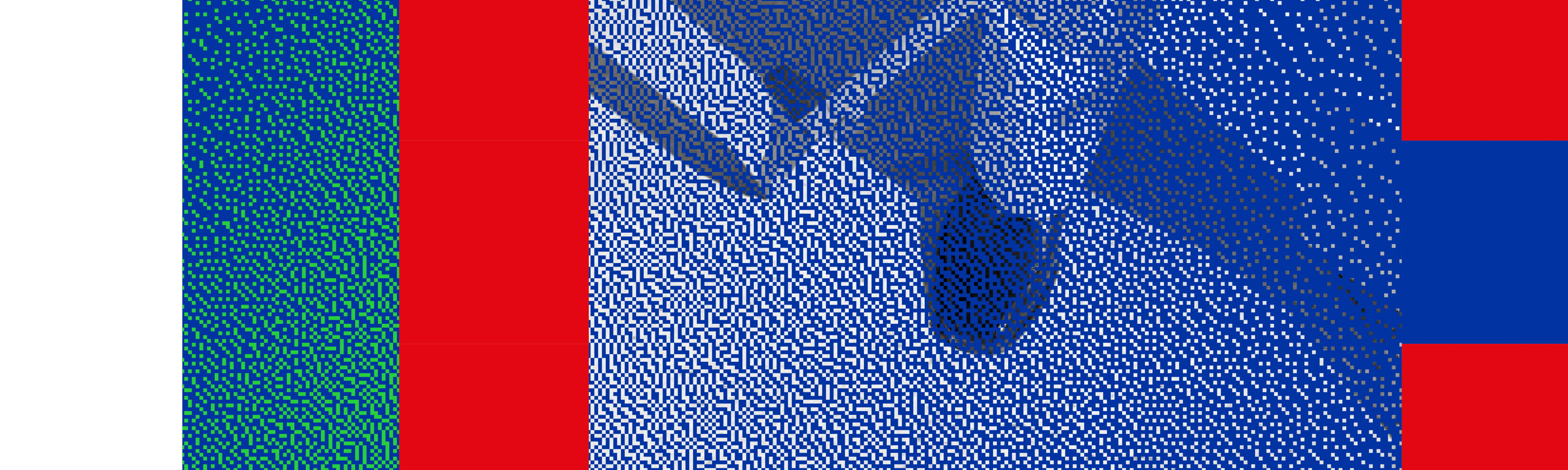
UFO. Unidentified Future Organizations Futuri preferibili per le organizzazioni che verranno
Un’esplorazione dal punto di vista del design sulle dimensioni estetiche, creative e territoriali delle organizzazioni, necessarie a ripensare spazi e tempi.
Quale può essere il ruolo del design per le Unidentified Future Organizations? Le possibilità che si aprono sembrano essere infinite e ciò richiede più progettualità per agire, nel cono dei futuri possibili (Voros, 2003), proprio all’interno delle opzioni preferibili. Ma un futuro preferibile dipende dai punti di vista con cui, qui e ora, leggiamo le organizzazio- ni. E questo punto di vista inevitabilmente dipende dall’ambiente che genera queste visioni. Il mio è quello della cultura del progetto e da qui prenderò spunto per argomentare questi potenziali scenari. Ovviamente nell’ambito della cultura del progetto potrebbero ancora esserci n possibili letture che, per sensibilità e affinità con contenuti e temi di questa cultura, riporterei a tre argomenti chiave: leggere l’organizzazione come un fatto estetico, capire il ruolo della creatività come motore evolutivo della stessa, leggere nel rapporto con la città una opportunità significativa per il lavoro prossimo futuro.
Vediamo gli antefatti. Se parliamo di UFO – acronimo proposto dalla redazione di Weconomy – è (anche) perché tutti noi abbiamo avuto un’esperienza dirompente come quella della pandemia e del relativo lockdown. Un impatto su diverse attività della quotidianità, incluso il lavoro. In effetti i dati dei rapporti ISTAT ci quantificano l’entità di questo cambiamento: se nel 2019, prima della pandemia, solo lo 0,8% degli occupati usava la propria casa come luogo principale per il lavoro (per arrivare complessivamente a un 6%, includendo quelli che usavano casa come luogo secondario per il lavoro o per situazioni sporadiche), durante il lockdown quasi un quarto degli occupati ha usato la propria abitazione come workspace. Lo stesso istituto ha inoltre verificato che i lavoratori smart potenziali stimati potrebbero essere il 36% degli occupati, più di 8 milioni di persone. Un nuovo paradigma. Questo salto è stato favorito dalle tecnologie digitali e dalla loro diffusione e accessibilità a livello globale. C’è da dire che queste tecnologie erano già lì disponibili e che la pandemia ne ha semplicemente diffuso la conoscenza e implementato l’uso. In ogni caso non possiamo trascurare l’impatto che la trasformazione digitale, già prima dell’evento pandemico, stava inducendo nel mondo del lavoro.
In un futuro preferibile l’organizzazione avrà (ancora di più) una valenza estetica.
Per argomentare questo scenario è utile fare riferimento al tema della dimensione estetica nella vita organizzativa che si è rivelato tra la fine dello scorso secolo e l’inizio di questo. È un ambito che mette insieme aspetti di sociologia, semiotica, estetica, antropologia e design. L’estetica organizzativa ha a che fare con la materialità della vita quotidiana all’interno delle organizzazioni.
L’estetica organizzativa consente di capire se un certo modo di lavorare è bello (o elegante) oppure no
Il tema “estetica” non è solo collegato all’idea di bello (che è un discorso spesso soggettivo e oggetto di nego- ziazione) ma alla sua radice etimologica: viene dal greco antico aisth e dal verbo aisthánomai, e significa conoscenza sensibile, quella che ottengo attraverso i sensi. È una conoscenza tacita, quindi difficilmente descrivibile. Nell’organizzazione rappresenta il modo con cui individui e gruppi agiscono praticamente, dando ascolto a desideri e sensazioni, talenti e passioni. Questa azione non avviene solo tra esseri umani ma anche grazie alla mediazione di artefatti e induce un processo negoziale per definire, insieme, le qualità estetiche di un prodotto, di un ambiente, di una sede di rappresentanza, di un flagship store, di un logo e anche il modo di relazione. È una relazione post-sociale perché determinata dalla capacità di indurre azioni negli uomini grazie a specifici artefatti organizzativi: sono spesso questi elementi non umani che condizionano il sistema di relazioni. Pensiamo, ad esempio, al ruolo che i workcafé svolgono oggi all’interno degli uffici, intesi come attivatori di relazione, spesso tra persone che appartengono a silos aziendali diversi, con legami deboli e, pertanto, messi nelle condizioni di attivare conversazioni spesso apripista per potenziali innovazioni (Granovetter, 1973). L’estetica organizzativa è anche quella che consente di capire se un certo modo di lavorare è bello (o elegante) oppure no. Si rivolge quindi ad aspetti fisici ma anche a dimensioni impalpabili (Strati, 2010). Nel modello di Edgar Schein, psicologo dell’organizzazione ed esperto di cultura organizzativa, questa dimensione impalpabile coincide con la dimensione degli assunti dell’organizzazione, una sorta di “curriculum nascosto” che percepisci, sebbene sia difficilmente esplicitabile, appena metti piede dentro una struttura organizzata (Schein, 1985). Estetica è anche l’atto del dare forma: “formare, dare forma, foggiare è cruciale per l’azione organizzativa e per la sua gestione, ed è un atto per cui la creatività non rimane circoscritta ai mondi dell’arte, ma riguarda l’organizzare…” (Strati, 2010). Questo punto di vista aggiunge un ulteriore tassello alla nostra lettura, perché il coinvolgimento “sensoriale” si traduce anche in una dimensione di operosità. Nel fare cose. E nel farle insieme.
Il farlo insieme però richiede presenza. E richiede contatto, anche tattile, che non potrà mai essere sostituito dallo screen-deal che pare apparire come una delle possibilità per il lavoro futuro. La dimensione estetica è un pezzo importante dell’organizzazione e richiede luoghi, artefatti e pratiche di prossimità.
La creatività, a livello organizzativo, non è un fenomeno solo individuale ma è un atto sociale
In un futuro preferibile l’organizzazione sarà creativa (o non sarà)
Una tecnologia sociale a disposizione dell’organizzazione per l’innovazione è sicuramente il design thinking (Lietdka, 2018). È tecnologia perché si realizza in set di strumenti e metodologie da gestire all’interno di gruppi e, per questo motivo, ha una dimensione sociale. È inoltre un mindset, almeno per chi si occupa di design e non (solo) di gestione dell’innovazione. Il design thinking infatti funziona (cioè ha un buon grado di successo nei processi di innovazione) quando viene integrato nella cultura organizzativa. In altre parole, quando emerge una fiducia diffusa nelle potenzialità di ognuno per un approccio creativo alle sfide che, di volta in volta, vengono poste. La creative confidence, codice sintetico con cui la letteratura indica questo fenomeno (Kelley and Kelley, 2013), è una conquista recente, spesso associata al tema dell’engagement del lavoratore: se ho un ambiente che dà tempo e spazio per individuare nuove opportunità per la mia organizzazione, mi sentirò più motivato e sentirò forte l’essere parte (importante) dell’organizzazione. Si chiede pertanto ai leader di essere loro per primi i creativi in capo, ma anche di costruire le condizioni e i dispositivi utili per amplificare le capacità creative delle persone che collaborano (collaboratori più che dipendenti). Sono ben chiare due cose in questo ragionamento. Da una parte che la turbolenza indotta da tecnologie dirompenti induce un atteggiamento favorevole alla creatività. Dall’altra emerge un’idea del lavoratore come persona-con-capacità che va incoraggiata per mettere on stage queste capacità (Sen, Nussbaum, 1993). Un inciso: il pensiero positivista e razionalista dell’organizzazione burocratica con le sue norme, i suoi dispositivi organizzativi, i suoi regolamenti, che tende a livellare tutti gli attori dell’organizzazione, viene seriamente compromesso (una grossa minaccia verso l’istituzionalizzazione dell’organizzazione) dalla scelta del “dare spazio” alla creatività di ognuno: perché, ça va sans dire, la creatività non può essere ingabbiata in norme e regolamenti e rifugge ogni forma di omogeneizzazione. La creatività, per come la possiamo leggere a livello organizzativo, non è un fenomeno solo individuale ma è un atto sociale: non ha senso una proposta se non c’è riconoscimento e negoziazione sociale della stessa (Csíkszentmihályi, 1996). Questa negoziazione ha bisogno di relazione, di spazi che la favoriscono, di strumenti e laboratori. Anch’essa è legata a una dimensione del fare insieme, con connotazioni artigianali, intendendo con ciò l’essere dentro l’atto del fare, con dedizione e passione (Sennett, 2014).
In un futuro preferibile il lavoro sarà integrato nella città della prossimità
È stato un urbanista franco-colombiano, Carlos Moreno, a introdurre il concetto di “città dei 15 minuti”, convincendo la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ad adottare un modello di decentralizzazione di servizi per favorire la rinascita di quartieri e periferie. Il concetto è semplice: abbandonare l’idea di una città organizzata spazialmente per funzioni e realizzare, invece, dei luoghi urbani dove in pochi minuti a piedi o grazie a mezzi di mobilità sostenibile, sia possibile raggiungere tutti quei servizi che rendono un luogo vivibile. Il sociologo americano Ray Oldenburg ha parlato qualche anno fa di terzi luoghi (Oldenburg, 1989) come degli spazi che oltre la domesticità e oltre il workplace, fanno acca- dere cose. E ciò che si verifica, seppure in forme ancora poco definite, è che i cosiddetti smart working places, come i bar, i ristoranti, gli alberghi, alcuni servizi, si attrezzano per accogliere lavoratori. Nell’immaginario della città di prossimità si prefigura un cottage di prossimità, spesso hub che offrono una gamma più ampia di servizi alle comunità locali. Sono piattaforme oggi associate quasi esclusivamente al co-working, ma che in futuro potrebbero configurarsi come attivatori e stimolatori di aggregazione e di creazione di comunità. Tutto questo, naturalmente, porta con sé l’esigenza di policies specifiche, di azioni dimostrative della bontà di questi modelli, di incontro e confronto tra pubblico e privato. Prevede soluzioni che non siano definitive, in forme capaci di ascolto, quasi soluzioni in beta, sempre aperte a potenziali miglioramenti e adattamenti. Include una ibridazione tra forme fisiche e digitali delle piattaforme, usando le seconde per favorire le prime. Anche perché la relazione, al centro di questa riflessione, ha bisogno di tattilità. O di erotismo, inteso come espressione concreta della corporeità (Hosoe, Marinelli, Sias 1991) nel rapporto con l’altro: le altre persone “non sono mai per me spirito: non li conosco che attraverso i loro sguardi, i loro gesti, le loro parole, in una parola, attraverso il loro corpo”. (Merleau-Ponty, 2002). L’altro, con il suo corpo, è quello di cui prendersi cura. L’ufficio di prossimità sarà luogo del contatto fisico, del lavoro, anche pratico, insieme, della cura. Una cura che con le parole di María Puig de la Bellacasa (2017), deve andare oltre l’umano per prendersi cura di ciò che ci circonda, riconoscendo l’interdipendenza dell’uomo con l’ecosistema che lo accoglie e che è, quasi irrimediabilmente, compromesso.
Il design contribuisce con i propri mezzi a rendere progettabile un futuro preferibile
Ritorniamo alla base. Ci occupiamo di design, una prassi e una meta-disciplina che mette insieme pezzi di conoscenze in un patchwork funzionale alle sfide che vengono poste. Sappiamo però con certezza che il design ha al centro la persona, la questione del dare forma, la dimensione estetica (nelle accezioni anche ampie che abbiamo argomentato). E ci troviamo, nel mondo del lavoro, come in tante altre espressioni dell’agire umano, di fronte ad un salto di paradigma. È Thomas Kuhn che ci ha insegnato come leggere il collasso di vecchi paradigmi e l’emergere del nuovo. In un suo libro lo stesso scrive che il “genere di considerazioni che può indurre uno scienziato ad abbandonare un vecchio paradigma a favore di uno nuovo” può essere costituito dalle argomentazioni “che di rado sono del tutto esplicite, che fanno appello alla sensibilità dell’individuo per ciò che è appropriato o presentano un aspetto esteticamente attraente: la nuova teoria viene presentata come più elegante, più adatta, più semplice della vecchia” (Thomas Kuhn, 1969).
Il ruolo del design, come delle altre discipline del progetto, è proprio questo. Contribuire, con i propri mezzi e le proprie abilità narrative, a rendere un futuro preferibile – e progettabile – elegante, attraente e adatto per il nuovo mondo che ci aspetta.




