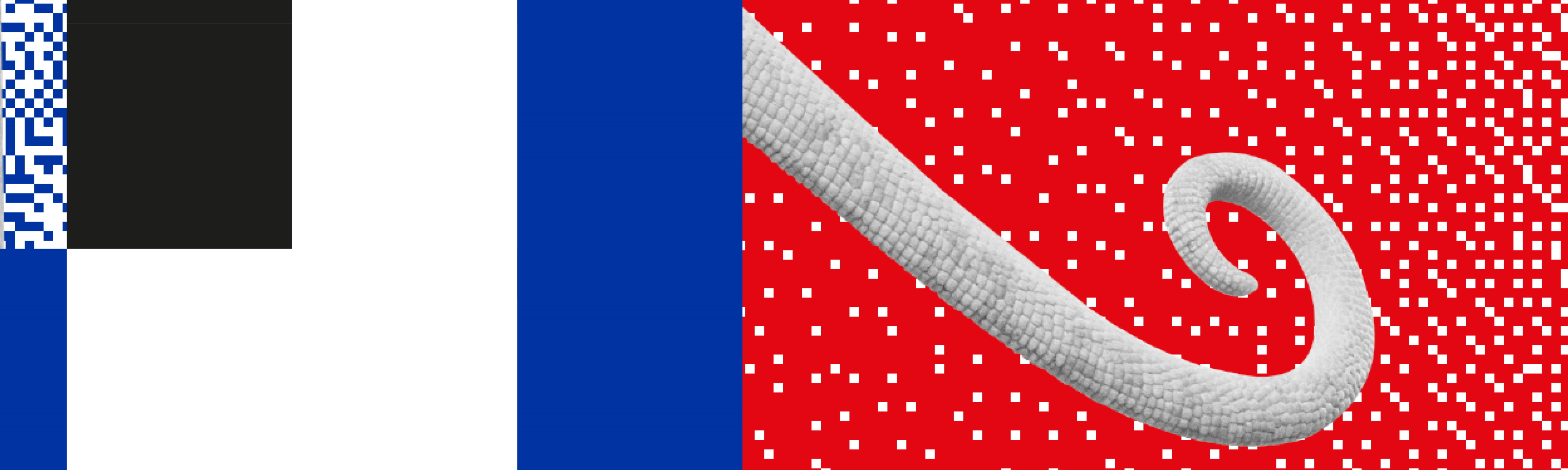
UFO. Unidentified Future Organizations Presenza-disponibilità: la riscoperta del mondo fisico
Quali sono gli effetti del lavoro digitale sulle relazioni umane e come ripensare il concetto di co-presenza fisica.
Nel mondo ci sono quasi otto miliardi di esseri umani e pochissimi non sono stati toccati dalla pandemia. Forse nessuno. Durante la primavera 2020, i negozi sono stati costretti alla chiusura, la libertà di spostamento è stata limitata dall’Argentina allo Zimbawe, alcune grandi aziende hanno rischiato la bancarotta mentre altre, tra quelle più piccole, sono sparite nel nulla. Le rate dei mutui non sono state pagate, gli studenti non hanno potuto svolgere gli esami, la situazione dei lavoratori precari nel sud del mondo si è fatta ancora più incerta e ci è stato insegnato di tenerci alla distanza di almeno un metro dall’altro. Non ci sono state strette di mano, né abbracci fraterni. I nostri nervi erano tesi e molti hanno potuto osservare per la prima volta in modo chiaro (altri in maniera più vaga) come funziona la globalizzazione, con le sue fabbriche intensamente connesse attraverso filamenti composti da catene di produzione, distribuzione e comunicazione. Legami che non sono mai più forti dell’anello più debole.
Mentre molti aspetti del mondo fisico rallentavano, l’accelerazione proseguiva nel digitale: dall’intrattenimento online, ai film, fino ai concerti. L’economia capitalistica globale, assuefatta alla crescita, è stata colpita, ma gli effetti dei lockdown e la decelerazione complessiva sono stati attenuati da una migrazione massiccia verso il cyberspazio, un mondo sempre più saturo di comunicazioni digitali.
Eppure la cosa più sorprendente della pandemia non riguarda la diffusione del lavoro digitale, piuttosto, che ciò non sia accaduto prima. Così come le lecture online (o le conferenze, i workshop e i meeting), anche lavorare da casa era già una possibilità reale per molti almeno dall’inizio del millennio. Sono passati molti anni da quando la più grande società di telecomunicazioni norvegese, Telenor, ha deciso di traslocare in un nuovo ufficio, creato per ospitare solo il 60% dei dipendenti. Al restante 40% veniva data la possibilità di lavorare da casa e di collaborare attraverso riunioni online, oppure di usare il proprio laptop da un aeroporto, un treno o una stanza d’albergo. Il management sembrava averci visto giusto. Ci sono state poche lamentele e i lavoratori di Telenor si sono abituati presto a portare con sé telefono e portatile e a trovare posto in una scrivania libera nelle stanze condivise dell’ufficio. I più strenui oppositori di questa modalità di lavoro erano limitati al reparto R&D (research & development), di formazione accademica. Alla fine, a malincuore, è stato loro offerto un cubicolo con alcuni scaffali per ospitare i libri. A quel tempo, i datori di lavoro erano preoccupati del fatto che, a casa, le persone sarebbero state meno diligenti e produttive, perché – al contrario di quanto accade in ufficio – non sarebbero stati sorvegliati dai colleghi e superiori. Invece si è verificato il problema opposto, come ho raccontato nel libro Tyranny of the moment (2001): i confini tra lavoro e tempo libero si sono confusi e, in alcuni casi, sono scomparsi del tutto. Molti si sono resi conto di non smettere mai davvero di lavorare.
Così la pratica del lavoro da casa è rimasta una tendenza latente, finché la pandemia non l’ha resa necessaria.
Abbiamo imparato tanto sul digitale, ma ancora di più sul mondo analogico
Molti allora hanno iniziato a preoccuparsi: la migrazione dal lavoro analogico a quello digitale avrebbe avuto impatti negativi. A inizio pandemia Naomi Klein, scherzandoci su, aveva affermato che anziché affrontare il “green new deal” ci siamo ritrovati a gestire uno “screen new deal”, con milioni di persone incatenate a un computer per produrre un surplus di valore per le aziende, senza possibilità di uscita. Rispetto a questa prima impressione, le cose si sono rivelate più complicate.
Dal punto di vista degli imprenditori, la digitalizzazione degli uffici può essere allettante. Durante la pandemia ho avuto occasione di parlare con molti executive sia nel settore pubblico sia in quello privato. Tutti hanno notato un incremento della produttività, perché da remoto viene dedicato meno tempo alle attività improduttive, come le chiacchiere con i colleghi. Se il lavoro da casa (o da un bar, dal treno, o da qualunque altro luogo) diventasse lo standard, ci sarebbe un beneficio ulteriore: gli uffici avranno bisogno di meno spazio.
Ci sono vantaggi anche per i dipendenti, che risparmiano tempo e denaro perché non è necessario spostarsi. Molti inoltre apprezzano l’efficienza delle riunioni via Zoom o Teams, perché permettono di dedicarsi ad altre attività. In un articolo apparso sul Guardian, Dan Price, Ceo di Gravity – società che si occupa di elaborare i pagamenti delle carte di credito –, ha affermato che il lavoratore medio negli Stati Uniti dedica agli spostamenti 55 minuti, ogni giorno. Nella primavera 2021, Price ha effettuato un sondaggio tra i suoi 200 dipendenti e si è scoperto che solo il 7% desiderava tornare a fare il pendolare. È sorprendente notare che la percentuale di chi ha affermato di prediligere una soluzione ibrida è limitata al 31%, mentre la maggioranza ha dichiarato di voler continuare a lavorare da casa. Certo, è poco probabile che l’azienda di Price sia rappresentativa. Si potrebbe presumere che, per la maggior parte dei lavori d’ufficio, inclusi quelli nell’accademia, la soluzione ibrida sia più adatta e flessibile, ma sembra comunque molto probabile che l’eredità più durevole della pandemia sarà l’aumento del remote working. Questa tendenza era in corso da tempo. Vent’anni fa Tian Sørhaug, un mio collega al Centro per la Tecnologia, Innovazione e Cultura dell’Università di Oslo, e a quei tempi il mio capo, osservò – quasi per caso – come sia diventato più importante essere online che on time (in orario). Finché raggiungi il risultato, puoi essere anche a Tahiti o lavorarci alle 4 del mattino.
Eppure si perde qualcosa di importante quando si abbandona la co-presenza fisica. Se non era già chiaro prima, con la pandemia è diventato palese. Il lavoro non è semplicemente un mezzo per generare valore, ha anche un ruolo sociale. Alcuni studi indicano come molte donne non entrano nel mercato del lavoro principalmente per il denaro, ma per le relazioni che si creano. Inoltre anche la produttività, se definita in senso stretto, può essere potenziata da incontri informali, chiacchierate durante il pranzo, pause caffè ecc. È sicuramente un punto di vista condiviso tra gli accademici. Trent’anni fa il sociologo Anthony Giddens, nel suo Modernity and Self-Identity, ha coniato un termine che merita più attenzione di quanta non ne abbia avuta: la presence-availability [presenza-disponibilità]. Per Giddens questa è la risorsa scarsa della modernità.
L’emergenza Coronavirus ci ha insegnato tanto sulle possibilità delle tecnologie digitali, ma ci ha permesso di imparare ancora di più sul mondo analogico. E ciò si applica anche ad altri territori, non solo al lavoro. Probabilmente tutte le forme di aggregazione sociale verranno ritenute ancora più preziose – dalle partite di calcio, ai concerti, fino ai pranzi di lavoro e alle feste –, perché ora abbiamo un’esperienza diretta su cosa significhi la loro assenza. A molti è mancato abbracciare e baciare qualcuno, ad altri la birra al pub dopo il lavoro.
Vincenzo Scagliarini, di Weconomy, parla di un “nuovo ecosistema di relazioni” che emergerà dopo la pandemia, e penso sia un buon modo per formulare la sfida che abbiamo davanti, perché gli umani sono esseri ecologici, tanto nel senso letterale quanto in quello metaforico. Nella dominante concettualizzazione dell’umanità, uno degli errori più comuni riguarda la “fallacia individualistica” e cioè ritenere che tu e io siamo “i capitani delle nostre anime”. Questo errore è già stato notato da molti, a partire dai pensatori ecologici come Bateson (Verso un’ecologia della mente, 1972) fino a scienziati cognitivisti come Sloman e Fernbach (The Knowledge Illusion, 2017). Questi ultimi in particolare sostengono che, al contrario di quanto si creda, gran parte della conoscenza non risiede nelle menti dei singoli, ma è condivisa da una comunità semiotica, un network di comunicazione. Il concetto di flusso (flow) ricercato dai sostenitori dello psicologo Csíkszentmihályi si attiva necessariamente in un contesto sociale, non individuale. Allo stesso modo l’“impalcatura semiotica” (semiotic scaffolding) descritta dal biosemiologo Hoffmeyer è una precondizione per raggiungere il proprio potenziale, ovvero la “libertà semiotica”, che è composta da input, possibilità e stimoli provenienti dall’Umwelt e cioè l’ambiente.
Gli eventi digitali non lasciano ricordi, perché la comunicazione è limitata agli schermi
La questione urgente, quindi, riguarda gli effetti del lavoro digitale sulle relazioni umane che abbiamo bisogno di far prosperare. Perché, nel tempo, molti hanno accusato affaticamento (la Zoom fatigue), perdita di energia e motivazione. A partire dal marzo 2020 ho tenuto più di cento lecture e talk e la stanchezza che mi lasciavano è diversa da ciò che provavo nell’equivalente fisico. Una lecture online ti lascia vuoto e prosciugato, anziché esausto ma rinvigorito. E questo perché, in digitale, la comunicazione con il pubblico è limitata agli schermi. Mentre la maggior parte di ciò che accade tra le persone è non-verbale. Per esprimerci, quando parliamo, abbiamo a disposizione il linguaggio del corpo, i gesti, gli odori, il contatto visivo e molti altri aspetti che, sebbene più difficili da individuare, dipendono sempre dall’essere nella stessa stanza. Le conferenze su Zoom invece non lasciano ricordi. Non ci sono pause caffè, nessuna stretta di mano, nessun abbraccio, nessuna camminata svagata verso il ristorante. Questi eventi sono limitati, contingentati e computerizzati, perché l’obiettivo è far palesare il contenuto. Penso quindi che la presenza-disponibilità continuerà a essere la principale risorsa scarsa, nel presente come nel futuro prossimo.
La pandemia ci ha insegnato tanto sul mondo digitale, ma ancora di più sul mondo fisico, che ora è diventato qualcosa da bramare perché è una fonte di energia, motivazione e appagamento esistenziale. Ecco perché sostituire totalmente la co-presenza fisica con il lavoro digitale sarebbe un esperimento con conseguenze gravi e potenzialmente pericolose. E non si dovrebbe permettere che accada.




